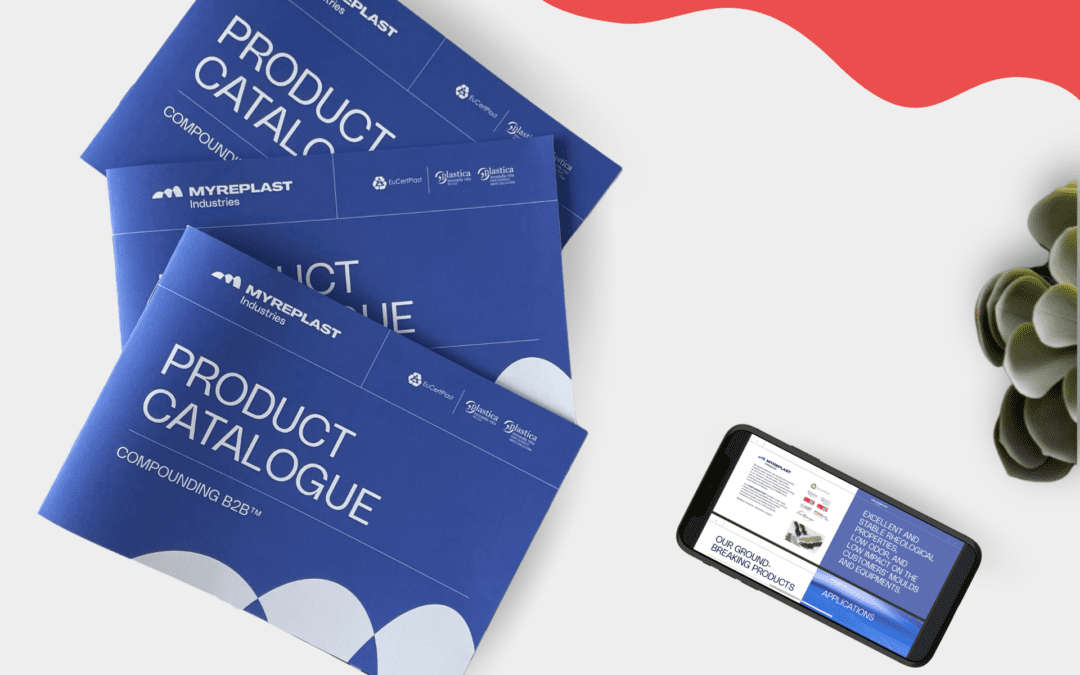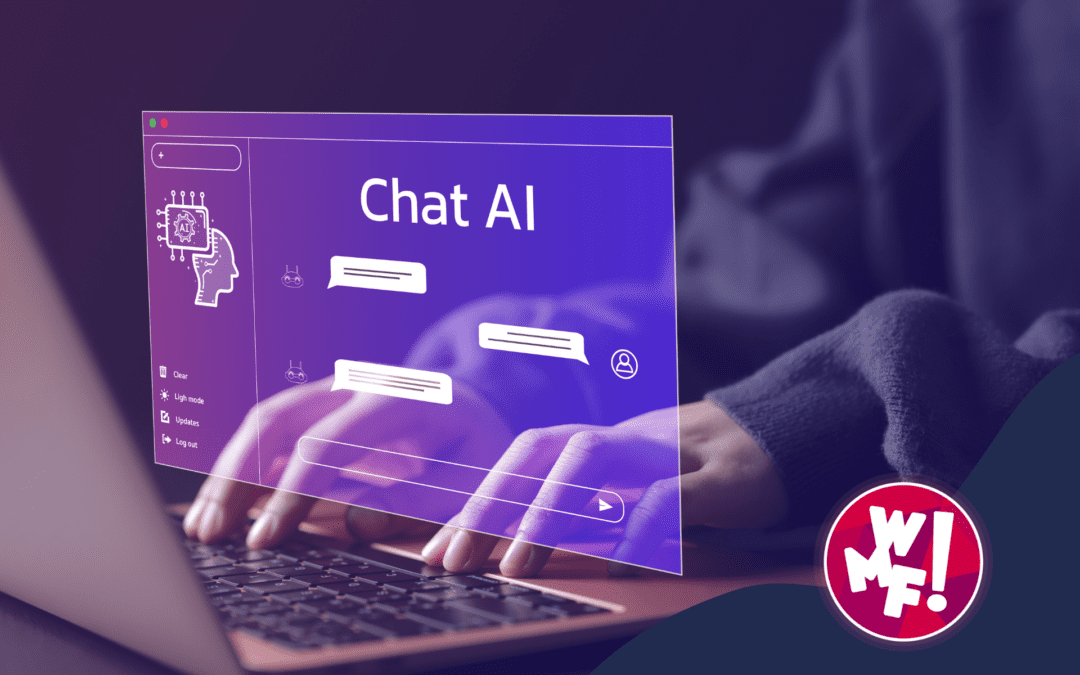Come innovare la propria azienda con la sicurezza psicologica
È il marzo 1977, siamo a Los Rodeos, un piccolo aeroporto di Tenerife. Due Boeing 747 si sono appena scontrati, uccidendo 583 persone. Una tragedia.
Ci credereste se vi dicessi che tutto è successo a causa della bassa sicurezza psicologica di due piloti?
La pista era fitta di nebbia, l’aeroporto era piccolo, poche ore prima c’era stato un allarme terroristico che aveva costretto alcuni aerei ad atterraggi d’emergenza e il personale della torre di controllo probabilmente era distratto da un evento sportivo in corso. Condizioni decisamente sfavorevoli, ma relativamente comuni e che, in realtà, non rappresentano la vera causa del disastro. All’interno della cabina di pilotaggio si trovano il comandante Van Zanten, meglio conosciuto come Mr. KLM in quanto addestratore di tutti i piloti esperti di KLM e colui che poteva emettere i brevetti di pilotaggio, e due piloti anziani con un grande livello di esperienza, Meurs e Schreuder. Non gli ultimi arrivati dunque. Al momento del decollo Van Zanten cominciò ad avanzare con impazienza e Meurs, un po’ titubante, segnalò al capitano che la torre di controllo non aveva ancora dato il permesso.
Il capitano ordinò a Meurs di chiedere l’autorizzazione, il quale si premurò subito di eseguire la richiesta. La torre di controllo diede le coordinate per la partenza, ma non disse «procedere al decollo». Van Zanten però procedette, e, nonostante il dubbio ri-sottoposto da Meurs, non si fermò. Schreuder, terzo pilota, osò dire «Ma quindi la pista è libera?» e van Zanten lo zittì con un sì deciso. Lo scambio di battute tra i due finì con Schreuder bloccato dalla sensazione di inadeguatezza. La sua segnalazione era corretta, ma i tre piloti se ne accorsero troppo tardi.
Ecco come nacque il peggior incidente della storia dell’aviazione civile.
L’inesorabile forza della gerarchia si era dimostrata nella sua massima forma tanto da rendere ciechi i due piloti di fronte a conseguenze grandi quanto la loro stessa morte. Tutto questo si sintetizza nella paura.
Avete mai avuto paura di parlare e subire il giudizio degli altri? Paura di sembrare ignoranti e incompetenti?
Questa condizione, quella capitata anche a Meurs e Schreuder, viene chiamata rischio relazionale. Il rischio relazionale è la paura di essere rimproverati e puniti, è il timore di subire conseguenze pratiche che ci danneggiano. Questa dinamica avviene in ogni dimensione aziendale e serpeggia a causa dell’impossibilità di sentirsi liberi di ammettere le proprie paure, o liberi di esprimersi senza rischiare di risultare ignoranti.
Il rischio relazionale risponde alla domanda: «Ma chi me lo fa fare?»
Il punto, però, è un altro. Oggi non possiamo più permetterci questo tipo di atteggiamento. Diciamo che il caso sopra citato ne è un esempio estremo, vero, ma viviamo in un’epoca in cui ogni lavoratore è chiamato a rispondere a continue micro-decisioni di cui è responsabile, e in cui le informazioni utili non arrivano dall’alto della gerarchia, ma anche da colleghi, dai clienti e dai partner. Un’epoca che vive di continui cambiamenti – anche piuttosto repentini – e che, proprio per questo, non permette di rinunciare al contributo di ogni singolo lavoratore in termini di pensiero, iniziativa e assunzione di responsabilità.
La paura di esporsi, l’immobilismo dato dal “chi me lo fa fare”, genera giganteschi costi, non solo alle aziende, ma anche ai professionisti. Lavorare fearless, senza paura, è necessario in un mondo che ci chiede di imparare costantemente mentre lavoriamo. Solo così saremo in grado di vedere rischi, opportunità e rispondere consapevolmente alle micro-decisioni da prendere.
Per un’azienda, quindi, è essenziale per la sopravvivenza cercare di attivare dei meccanismi che stimolino la sicurezza psicologica. Sembra una rivelazione banale, praticamente ovvia, ma capire che la paura di assumersi rischi relazionali è strettamente collegata al livello di sicurezza psicologica che un ambito di lavoro offre, è il primo passo che porta ad agire. Inoltre, è importante non confondere la sicurezza psicologica con il sostegno incondizionato. Non è fiducia a prescindere, non significa non subire conseguenze: la sicurezza psicologica rappresenta l’aria che si respira quotidianamente in ogni gruppo di lavoro, comprende le logiche implicite che diventano convinzioni comuni, quelle regole mai dichiarate, ma che esistono, su ciò che si può o non si può dire e che, inevitabilmente, diventano parte dei calcoli che regolano il modo in cui le persone si esprimeranno.
È un’esperienza immediata. La si misura attraverso la schiettezza nelle comunicazioni e la si valuta nell’impegno delle persone ad avere confronti e discussioni produttive.
Si nota anche sulla base della quantità di idee che vengono proposte, dalle domande fatte, dalla condivisione di errori e preoccupazioni. Proprio sugli errori ritengo importante invitarvi a riflettere: è possibile misurare la sicurezza psicologica dalla propensione a imparare dagli errori e dalla capacità di non cadere in errori evitabili. Ciò avviene soltanto quando le persone usano le richieste di aiuto e le sperimentazioni senza timori.
Interessante è notare come la sicurezza psicologica sia alimentata e si alimenti quotidianamente con l’impegno a migliorare e a imparare. Senza uno sforzo in termini di qualità, questa non esiste. È quindi lontana dal concetto di abbassamento dei risultati e richiede l’assunzione di responsabilità per generare valore. Innalzamento degli standard, aumento della creatività, gioco di squadra, maggior livello di comprensione, proposta, azione e sperimentazione: questi sono solo alcuni dei vantaggi che lavorare fearless genera, e da cui ogni organizzazione può attingere.
Cruciale è comprendere che la psychological safety è una dinamica che non arriva solo dall’organizzazione, ma si sviluppa tra diversi soggetti: la cultura aziendale, i leader, i team e le persone. È chiaro che i più coinvolti, per posizione, sono i manager in quanto responsabili degli effetti generati dalla propria leadership (o nelle fasce alte della gerarchia), ma la possibilità di migliorare o tenere alta la sicurezza rientra nelle facoltà di tutti.
Ciò che alimenta la paura è anche il modello di leadership scelto: vi sono molti esempi di come i CEO hanno attivato azioni ad hoc per trasformare la paura in potenza positiva, orgoglio e intraprendenza. Queste aziende hanno compreso che stimolare tutti i giorni le persone a esprimersi, a confrontarsi con schiettezza, trasparenza e umiltà all’interno della vita aziendale è più conveniente sia in termini di benessere psico-fisico dei dipendenti che economici per il business.
Tutto molto bello sulla carta, ma come fare?
Si potrebbe dire che esistono tre macro aree di azione per stimolare questo atteggiamento evolutivo ricco di consapevolezza.
Il primo passo è impostare il lavoro, creare le condizioni per mettere in pratica l’atteggiamento Fearless. In questa fase si dovrebbe lavorare sulle aspettative in termini di operatività e obiettivi.
Gli obiettivi che sto chiedendo di raggiungere al mio team sono chiari, condivisi e, soprattutto, raggiungibili? Il percorso che sto proponendo è fattibile? Il team crede in quello che sta facendo?
In questo modo è possibile capire quando ci si trova davanti a un vero fallimento e valutare i risvolti per migliorarsi e sviluppare nuove competenze sulla base delle esperienze acquisite.
Analizzare i fallimenti in maniera razionale garantisce al team la sicurezza necessaria per testare nuove strade. È essenziale poi far luce su incertezze e interdipendenze per capire le dinamiche utili all’espressione di tutti, oltre che chiedersi il perché di certi atteggiamenti o di certe dinamiche apparentemente scontate.
È importante mostrare come un capo abbia sì, la responsabilità finale, ma non “la verità in tasca”. Può sembrare scontato, ma l’umiltà, la condivisione e le risposte ragionate e non umorali a fallimenti sono la chiave. Un leader, per prima cosa, deve smettere di generare paura, definire obiettivi possibili e condividerli per motivare i team.
Il secondo step è quello di invitare alla partecipazione: inserire un metodo in grado di innescare in ogni componente del team la volontà di mettersi in gioco in prima persona. Questo passo è in diretto collegamento con il primo in quanto si basa sull’umiltà, intesa come la capacità dei leader di riconoscere se si dispone o meno di strumenti, competenze o risposte in merito a una determinata situazione. Se questo atto viene abbinato a buone domande – domande potenti – riusciremo a stimolare il contributo dei team.
Per porre una buona domanda, il leader non deve solo essere consapevole di non conoscere la risposta, ma deve far sì che le risposte siano il più aperte possibili.
Le domande potenti sono uno strumento essenziale per i leader: sono quesiti che, se posti in maniera completamente neutra e privi di sarcasmi, portano la persona a reagire senza pensare a conseguenze e quindi in totale modalità Fearless.
Una domanda, per essere considerata potente, deve avere determinate qualità, come:
- stimolare la curiosità dell’interlocutore e la conversazione;
- far riflettere e mettere in discussione preconcetti e strade battute;
- generare un moto progressivo e non legato a situazioni passate;
- suscitare ulteriori riflessioni e domande;
- considerare l’interlocutore che si ha di fronte.
Porre domande di questo tipo è sicuramente un’arte, ma cimentarsi a piccoli step può portare a risultati immediati. L’invito alla partecipazione, inoltre, deve essere reso possibile attraverso sistemi e metodi di contributo messi a disposizione dalle organizzazioni.
Questa area di azione è strettamente collegata alla tipologia di business e quindi non imbrigliabile in uno schema. Va definita internamente, magari tramite l’ausilio di un consulente esperto sul tema, considerando tutti gli attori in campo in modo da renderla veramente efficace.
Il terzo e ultimo passo è quello legato all’azione, al reagire in modo produttivo. In questa fase è necessario capire che la responsabilità in merito alla costruzione di un clima fearless nei team è in capo a tutti. Se i leader sapranno dare l’esempio ed essere dei catalizzatori per favorire l’espressione, allora anche le altre persone si attiveranno in questa direzione. Allo stesso modo, qualsiasi sia la nostra posizione lavorativa, possiamo contribuire a creare un clima di libertà e sicurezza, condivisione e progresso. Questo meccanismo di co-creazione si alimenta attraverso l’esempio, gli apprezzamenti e le considerazioni sugli errori.
La possibilità di contestualizzare un fallimento come naturale conseguenza di una sperimentazione che porta a nuove consapevolezze e competenze, permette di attivare discussioni schiette che portano a una capacità di apprendimento più rapida – decisamente utile di questi tempi.
Se però anche contestualizzando l’errore, si incappa in situazioni evitabili o ripetute, è necessario prendere provvedimenti in modo da responsabilizzare tutto il team.
I provvedimenti possono essere di diverso tipo: tra i più gravi vi sono il licenziamento o le sanzioni, ma non si esclude di prendere in considerazione della formazione aggiuntiva o l’analisi e la ridefinizione delle procedure utilizzate.
Lavorare su se stessi e sull’analisi delle situazioni, migliorarsi mettendo a disposizione le proprie competenze e agire per salvaguardare la sicurezza psicologica sono quei pilastri da considerare quotidianamente per salvaguardare un’organizzazione Fearless e mantenere rinnovata la spinta verso il progresso. Liberarci dalla paura è il primo passo che possiamo fare per non farci scappare le occasioni evolutive.
Al giorno d’oggi esistono diversi framework, racconti e consulenti in grado di aiutare i leader a raggiungere questo obiettivo. Chiaro è che il cammino è uno solo, e da fare insieme.